|
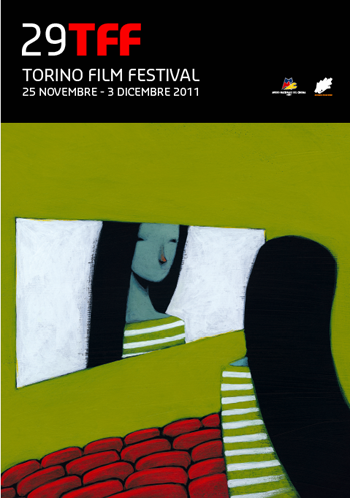 Vista la conferma dei vertici e la soddisfazione generale suscitata dalle ultime edizioni era prevedibile che il ventinovesimo Torino Film Festival si collocasse, purtroppo, sulla strada intrapresa dai precedenti quattro (quelli, per intendersi, diretti da “personalità illustri”). La sezione competitiva - un tempo luogo di tante scoperte - è così definitivamente diventata una vetrina nella quale esporre numerosi esemplari di “film da festival” raccolti, senza troppo sforzo, nelle sezioni collaterali di Cannes e Berlino, oppure nei concorsi delle rassegne più piccole. Una lunga panoramica su quella tipologia di cinema che da una quindicina di anni affolla i festival internazionali, e si ripete in forme (diverse a seconda dell’area geografica di provenienza) costruite a tavolino quanto quelle mainstream; forme che sono soltanto maniera vuota, prive di qualunque scarto vitale, incapaci di colpire allo stomaco perché pensate troppo con la testa, e sentite poco con il cuore. Un’esposizione dunque a uso e consumo di un “pubblico” (parola generica che significa tutto e niente) il cui sguardo viene, con poco rispetto, dato per scontato nella sua immobilità, e di conseguenza assecondato piuttosto che scosso, spostato, ridefinito. Vista la conferma dei vertici e la soddisfazione generale suscitata dalle ultime edizioni era prevedibile che il ventinovesimo Torino Film Festival si collocasse, purtroppo, sulla strada intrapresa dai precedenti quattro (quelli, per intendersi, diretti da “personalità illustri”). La sezione competitiva - un tempo luogo di tante scoperte - è così definitivamente diventata una vetrina nella quale esporre numerosi esemplari di “film da festival” raccolti, senza troppo sforzo, nelle sezioni collaterali di Cannes e Berlino, oppure nei concorsi delle rassegne più piccole. Una lunga panoramica su quella tipologia di cinema che da una quindicina di anni affolla i festival internazionali, e si ripete in forme (diverse a seconda dell’area geografica di provenienza) costruite a tavolino quanto quelle mainstream; forme che sono soltanto maniera vuota, prive di qualunque scarto vitale, incapaci di colpire allo stomaco perché pensate troppo con la testa, e sentite poco con il cuore. Un’esposizione dunque a uso e consumo di un “pubblico” (parola generica che significa tutto e niente) il cui sguardo viene, con poco rispetto, dato per scontato nella sua immobilità, e di conseguenza assecondato piuttosto che scosso, spostato, ridefinito.
 Se nelle precedenti edizioni - sempre coordinate da Emanuela Martini e dalla “sua squadra” di selezionatori - qualche visione insolita era stata in grado di rompere lo schema generale (comunque già decisamente percepibile) di un concorso accomodato e accomodante, quest’anno, invece, quasi niente sembra perforare la superficie uniforme e piatta (piattezza di stile e sopratutto di riflessione) costituita da film forzatamente d’autore. Film con vezzi ed estetiche riproducibili in serie ma che dell’autore non hanno che la patina; autorialità formato brand adatta a questo tempo che corre (senza muoversi mai). I titoli premiati dalla giuria sono in questo senso casi abbastanza paradigmatici, che ben descrivono Torino 29, a partire dal vincitore Á Annan Veg/Either Way. Il film di Sigurdsson inizia con una didascalia che colloca la vicenda nell’Islanda degli anni Ottanta, ma potrebbe situarla in qualunque altra epoca, così come in qualunque altro luogo suggestivo a livello paesaggistico: il contesto, qui come nella gran parte delle opere viste in concorso, ha il valore di una cartolina. Ciò che conta è la storia minima dei due protagonisti; figure agli antipodi che ovviamente non potranno che avvicinarsi attraverso una serie di eventi frammentari dal sapore programmaticamente grottesco, svagato e surreale, mai capaci però di rendere la carne di un'amicizia ai margini del mondo intero. Stesso discorso si può fare per 17 Filles (Premio della giuria), che prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto in una scuola della provincia americana, dove 17 ragazze della stessa classe sono rimaste incinte nel giro di poche settimane. Le due registe francesi costruiscono il loro fragile film esclusivamente sul riverbero del mare bretone, sulle immagini sterili di lunghi capelli al vento e del sole riflesso nella lente della macchina da presa. E così quello che poteva essere il racconto del disagio giovanile nel caos sentimentale e affettivo, oltre che politico, dell’era postindustriale perde qualunque legame con il reale, rimanendo l’esile ritratto manierato di un gruppo di adolescenti delimitato da una cornice morale vaga e ambiguamente conservatrice. Se nelle precedenti edizioni - sempre coordinate da Emanuela Martini e dalla “sua squadra” di selezionatori - qualche visione insolita era stata in grado di rompere lo schema generale (comunque già decisamente percepibile) di un concorso accomodato e accomodante, quest’anno, invece, quasi niente sembra perforare la superficie uniforme e piatta (piattezza di stile e sopratutto di riflessione) costituita da film forzatamente d’autore. Film con vezzi ed estetiche riproducibili in serie ma che dell’autore non hanno che la patina; autorialità formato brand adatta a questo tempo che corre (senza muoversi mai). I titoli premiati dalla giuria sono in questo senso casi abbastanza paradigmatici, che ben descrivono Torino 29, a partire dal vincitore Á Annan Veg/Either Way. Il film di Sigurdsson inizia con una didascalia che colloca la vicenda nell’Islanda degli anni Ottanta, ma potrebbe situarla in qualunque altra epoca, così come in qualunque altro luogo suggestivo a livello paesaggistico: il contesto, qui come nella gran parte delle opere viste in concorso, ha il valore di una cartolina. Ciò che conta è la storia minima dei due protagonisti; figure agli antipodi che ovviamente non potranno che avvicinarsi attraverso una serie di eventi frammentari dal sapore programmaticamente grottesco, svagato e surreale, mai capaci però di rendere la carne di un'amicizia ai margini del mondo intero. Stesso discorso si può fare per 17 Filles (Premio della giuria), che prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto in una scuola della provincia americana, dove 17 ragazze della stessa classe sono rimaste incinte nel giro di poche settimane. Le due registe francesi costruiscono il loro fragile film esclusivamente sul riverbero del mare bretone, sulle immagini sterili di lunghi capelli al vento e del sole riflesso nella lente della macchina da presa. E così quello che poteva essere il racconto del disagio giovanile nel caos sentimentale e affettivo, oltre che politico, dell’era postindustriale perde qualunque legame con il reale, rimanendo l’esile ritratto manierato di un gruppo di adolescenti delimitato da una cornice morale vaga e ambiguamente conservatrice.
 Anche l’altro film premiato dalla giuria, Tayeb, Khalas, Yalla/Ok, Enough, Goodbye, pur stilisticamente ed esteticamente piuttosto lontano dai primi due, si colloca in questa ipotetica tipologia di opere. Storia di una maturità quasi irraggiungibile nel Libano contemporaneo, tra ambizioni sociologiche (i superflui inserti documentaristici), ellissi narrative e situazioni fotocopiate male da Kaurismaki e Wes Anderson. L’ennesima riflessione sulla solitudine nel contemporaneo dal tono farsesco che non riesce a far ridere né tantomeno pensare. Fanno ugualmente parte dei film in tutto e per tutto “da festival”, anche se diversi tra loro oltre che diversamente riusciti: Vergiss Dein Ende/Way Home, Serdca Boomerang/Heart’s Boomerang, Le Vendeur, Seh-O-Nim/Three And a Half, Ganjeung/A Confession. Dei primi tre, tutti di matrice europea (Le Vendeur è canadese, però francofono), quello tedesco, Vergiss Dein Ende, è sicuramente l’esempio peggiore di una forma che si costruisce solo sull’accumulo di stereotipi stilistico-narrativi. Nel film di Kennengiesser ci sono condensati, in novanta minuti scarsi, la vecchiaia, la malattia, la famiglia in crisi, l’amore omosessuale, il rumore del vento, l’erba fluttuante, il bagno nel mare freddo di due anziani nudi, ecc... Un sovrapporsi infinito di dolori, nessuno però raccontato a fondo, nessuno oltre la superficie di immagini da accademia. Il problema di questo tipo cinema è l’incapacità di generare empatia pur cercandola continuamente; l’inconsistenza di storie che vorrebbero essere forti ma sono prive di centro, storie che vanno in tante direzioni senza dedicare mai la dovuta attenzione a personaggi ai quali, forse, non si tiene abbastanza. Anche l’altro film premiato dalla giuria, Tayeb, Khalas, Yalla/Ok, Enough, Goodbye, pur stilisticamente ed esteticamente piuttosto lontano dai primi due, si colloca in questa ipotetica tipologia di opere. Storia di una maturità quasi irraggiungibile nel Libano contemporaneo, tra ambizioni sociologiche (i superflui inserti documentaristici), ellissi narrative e situazioni fotocopiate male da Kaurismaki e Wes Anderson. L’ennesima riflessione sulla solitudine nel contemporaneo dal tono farsesco che non riesce a far ridere né tantomeno pensare. Fanno ugualmente parte dei film in tutto e per tutto “da festival”, anche se diversi tra loro oltre che diversamente riusciti: Vergiss Dein Ende/Way Home, Serdca Boomerang/Heart’s Boomerang, Le Vendeur, Seh-O-Nim/Three And a Half, Ganjeung/A Confession. Dei primi tre, tutti di matrice europea (Le Vendeur è canadese, però francofono), quello tedesco, Vergiss Dein Ende, è sicuramente l’esempio peggiore di una forma che si costruisce solo sull’accumulo di stereotipi stilistico-narrativi. Nel film di Kennengiesser ci sono condensati, in novanta minuti scarsi, la vecchiaia, la malattia, la famiglia in crisi, l’amore omosessuale, il rumore del vento, l’erba fluttuante, il bagno nel mare freddo di due anziani nudi, ecc... Un sovrapporsi infinito di dolori, nessuno però raccontato a fondo, nessuno oltre la superficie di immagini da accademia. Il problema di questo tipo cinema è l’incapacità di generare empatia pur cercandola continuamente; l’inconsistenza di storie che vorrebbero essere forti ma sono prive di centro, storie che vanno in tante direzioni senza dedicare mai la dovuta attenzione a personaggi ai quali, forse, non si tiene abbastanza.
 Decisamente meglio è Serdca Boomerang, opera russa di Nikolay Khomeriki che, sebbene abbia il sapore delle cose già viste, riesce a costruirsi attorno a un personaggio e una vicenda dai contorni abusati con un certa consapevolezza del mezzo e della tradizione cinematografica della modernità russa, e non solo. Con un bianco e nero asciutto dai contrasti sfumati che virano tutto al grigio, Khomeriki mette in scena una solitudine senza scampo, quella del protagonista malato - di un male invisibile che lo ucciderà all’improvviso (in fondo la malattia di ognuno) -, lasciando spazio a una quotidianità raccontata senza ruffianerie, piatta, forse noiosa ma con frammenti di verità. È un buon film anche Le Vendeur, forse il più “risolto” del concorso (premio FIPRESCI), quello in cui lo sguardo del regista, Sébastien Pilote, pur mediato e a tratti scontato, è in grado di restituire in modo sottile qualcosa che va oltre i confini del ritratto di un venditore d’auto infinitamente solo. Eppure anche il film di Pilote, benché indubbiamente migliore rispetto alla media di Torino 29, finisce con il lasciare freddi, “perché sotto si intravede il banco” e la sua scrittura, lavorando forzatamente per sottrazione, ci allontana dal dramma dei personaggi e dei lori mondi in crisi. Decisamente meglio è Serdca Boomerang, opera russa di Nikolay Khomeriki che, sebbene abbia il sapore delle cose già viste, riesce a costruirsi attorno a un personaggio e una vicenda dai contorni abusati con un certa consapevolezza del mezzo e della tradizione cinematografica della modernità russa, e non solo. Con un bianco e nero asciutto dai contrasti sfumati che virano tutto al grigio, Khomeriki mette in scena una solitudine senza scampo, quella del protagonista malato - di un male invisibile che lo ucciderà all’improvviso (in fondo la malattia di ognuno) -, lasciando spazio a una quotidianità raccontata senza ruffianerie, piatta, forse noiosa ma con frammenti di verità. È un buon film anche Le Vendeur, forse il più “risolto” del concorso (premio FIPRESCI), quello in cui lo sguardo del regista, Sébastien Pilote, pur mediato e a tratti scontato, è in grado di restituire in modo sottile qualcosa che va oltre i confini del ritratto di un venditore d’auto infinitamente solo. Eppure anche il film di Pilote, benché indubbiamente migliore rispetto alla media di Torino 29, finisce con il lasciare freddi, “perché sotto si intravede il banco” e la sua scrittura, lavorando forzatamente per sottrazione, ci allontana dal dramma dei personaggi e dei lori mondi in crisi.
 Gli altri due film, quello iraniano e quello coreano, rispecchiano fedelmente la produzione “festivaliera” dei due paesi. Seh-O-Nim/Three And a Half di Naghi Nemati guarda senza nasconderlo al cinema di Panahi, organizzandosi intorno a sfasamenti diegetici incapaci però di produrre significato, che rimangono vaga posa stilistica e complicano inutilmente una vicenda retta dal non detto e dal caso, che già da sola fatica a rimanere in piedi. Inoltre, forse a causa dello stretto controllo che Tehran esercita sull’intera produzione cinematografica, la storia delle tre donne di Nemati sembra non avere mai il respiro necessario per dare voce ai desideri di persone alle quali è negata la scelta in ogni momento del vivere pubblico e non solo. Ganjeung/A Confession di Park Su-min è invece una delle tante variazioni sul tema molto orientale del poliziotto violento che prova a scendere a patti con il suo passato, senza riuscirci. Tra colori grigi, flashback abbastanza prevedibili, riflessioni sul perdono, la necessità della fede e la sua oscenità, Su-min tratta una materia scottante senza troppe sbavature ma senza nemmeno voler provare ad andare oltre un esercizio di stile sull’impossibilità di redimersi da un male mai davvero indagato nelle sue profondità. Gli altri due film, quello iraniano e quello coreano, rispecchiano fedelmente la produzione “festivaliera” dei due paesi. Seh-O-Nim/Three And a Half di Naghi Nemati guarda senza nasconderlo al cinema di Panahi, organizzandosi intorno a sfasamenti diegetici incapaci però di produrre significato, che rimangono vaga posa stilistica e complicano inutilmente una vicenda retta dal non detto e dal caso, che già da sola fatica a rimanere in piedi. Inoltre, forse a causa dello stretto controllo che Tehran esercita sull’intera produzione cinematografica, la storia delle tre donne di Nemati sembra non avere mai il respiro necessario per dare voce ai desideri di persone alle quali è negata la scelta in ogni momento del vivere pubblico e non solo. Ganjeung/A Confession di Park Su-min è invece una delle tante variazioni sul tema molto orientale del poliziotto violento che prova a scendere a patti con il suo passato, senza riuscirci. Tra colori grigi, flashback abbastanza prevedibili, riflessioni sul perdono, la necessità della fede e la sua oscenità, Su-min tratta una materia scottante senza troppe sbavature ma senza nemmeno voler provare ad andare oltre un esercizio di stile sull’impossibilità di redimersi da un male mai davvero indagato nelle sue profondità.
 Sono allo stesso modo un esempio del panorama americano da esportazione anche i tre film USA visti in concorso. Win Win e 50/50, in particolare, sono il perfetto prodotto a marchio Sundance che vuole affrontare temi importanti e drammatici con toni da commedia. Film che vogliono far ridere e insieme riflettere, e talvolta ci riescono, ma il cui schema ripetitivo, furbo e spesso ricattatorio non può non irritare. E irrita, infatti, 50/50 di Jonathan Levine, irritano i Radiohead (High and Dry) nelle cuffie di Adam poco dopo la scoperta del cancro, irritano il suo simpatico levriero anziano, l’amico sessuomane, la terapeuta con cui puntualmente, una volta guarito, inizierà un rapporto lasciando la fidanzata antipatica, ecc…(l’elenco potrebbbe continuare a lungo). Irrita 50/50 perché è esattamente ciò che deve essere: un film indie sul cancro dove tutto è al posto giusto, dove tutto vuole colpire nei punti giusti, ma dove niente fa davvero male. Lo stesso si potrebbe dire per Win Win di Thomas McCharty, altro raccoglitore di temi e figure indie (malattia, perdente di mezza età, perdente adolescente, sport dai costumi buffi, ecc…), nel quale, però, una certa finezza di scrittura lascia intravedere qualcosa oltre la solida banalità della sua forma. Eppure, quasi niente alla fine impedisce di pensare che quella interpretata da Giamatti sia una storia uguale, ma proprio uguale, alle tante storie di riscatti che gravitano nell’orbita Sundance: pulita, gradevole, artefatta. Sono allo stesso modo un esempio del panorama americano da esportazione anche i tre film USA visti in concorso. Win Win e 50/50, in particolare, sono il perfetto prodotto a marchio Sundance che vuole affrontare temi importanti e drammatici con toni da commedia. Film che vogliono far ridere e insieme riflettere, e talvolta ci riescono, ma il cui schema ripetitivo, furbo e spesso ricattatorio non può non irritare. E irrita, infatti, 50/50 di Jonathan Levine, irritano i Radiohead (High and Dry) nelle cuffie di Adam poco dopo la scoperta del cancro, irritano il suo simpatico levriero anziano, l’amico sessuomane, la terapeuta con cui puntualmente, una volta guarito, inizierà un rapporto lasciando la fidanzata antipatica, ecc…(l’elenco potrebbbe continuare a lungo). Irrita 50/50 perché è esattamente ciò che deve essere: un film indie sul cancro dove tutto è al posto giusto, dove tutto vuole colpire nei punti giusti, ma dove niente fa davvero male. Lo stesso si potrebbe dire per Win Win di Thomas McCharty, altro raccoglitore di temi e figure indie (malattia, perdente di mezza età, perdente adolescente, sport dai costumi buffi, ecc…), nel quale, però, una certa finezza di scrittura lascia intravedere qualcosa oltre la solida banalità della sua forma. Eppure, quasi niente alla fine impedisce di pensare che quella interpretata da Giamatti sia una storia uguale, ma proprio uguale, alle tante storie di riscatti che gravitano nell’orbita Sundance: pulita, gradevole, artefatta.
 Diverso è invece il caso dell’altro film americano in concorso, A Little Closer, l’opera prima di Matthew Peatock, che, pur segnata da un’estetica e una struttura da scuola di arti visive, è incredibilmente onesta. È la prossimità ciò che la rende diversa, una prossimità emotiva reale che si riesce a sentire. A Little Closer è l’unico film in concorso a sembrare davvero sincero, in cui si avverte una reale vicinanza con i personaggi raccontati, tutti per mezzo di una spontanea e ostinata ingenuità, che può forse stancare, ma dalla quale, se si presta la dovuta attenzione, si è presi allo stomaco. Peatock, pur rimanendo ben attaccato con la macchina da presa ai suoi protagonisti, riesce, attraverso le loro quotidianità atrocemente banali, a mostrare con infinito rispetto una parte enorme di America ferita - economicamente e sentimentalmente -, patetica, disperata, eppure vitale. Un'America piena di dolore ma capace di amore, la stessa dei racconti di Raymond Carver, Tobias Wolff, Richard Ford, Russel Banks, ecc… Diverso è invece il caso dell’altro film americano in concorso, A Little Closer, l’opera prima di Matthew Peatock, che, pur segnata da un’estetica e una struttura da scuola di arti visive, è incredibilmente onesta. È la prossimità ciò che la rende diversa, una prossimità emotiva reale che si riesce a sentire. A Little Closer è l’unico film in concorso a sembrare davvero sincero, in cui si avverte una reale vicinanza con i personaggi raccontati, tutti per mezzo di una spontanea e ostinata ingenuità, che può forse stancare, ma dalla quale, se si presta la dovuta attenzione, si è presi allo stomaco. Peatock, pur rimanendo ben attaccato con la macchina da presa ai suoi protagonisti, riesce, attraverso le loro quotidianità atrocemente banali, a mostrare con infinito rispetto una parte enorme di America ferita - economicamente e sentimentalmente -, patetica, disperata, eppure vitale. Un'America piena di dolore ma capace di amore, la stessa dei racconti di Raymond Carver, Tobias Wolff, Richard Ford, Russel Banks, ecc…
 In concorso c’erano poi, ovviamente, i film italiani, una prerogativa della gestione Amelio, non curante del livello della produzione nel nostro paese (l’anno scorso in concorso c’era l’imbarazzante Henry di Alessandro Piva). I più grandi di tutti di Carlo Virzì, pur nella sua superficialità, si rivela un film dignitoso, capace di strappare qualche risata e soprattutto di fermarsi, evitando di prendersi sul serio e di scendere in profondità che evidentemente non gli appartengono. Una commedia leggera, senza pretese, che racconta con un certo affetto il mondo delle band di provincia e dei sogni infranti: nulla di più, forse non abbastanza per giustificarne la presenza a un festival. Ulidi piccola mia, invece, è un film piuttosto arrogante, fastidioso e soprattutto moralmente scorretto nell’appoggiarsi soltanto alla sofferenza delle sue protagoniste. Mateo Zoni mette in scena un gruppo di ragazze con problemi familiari e psichiatrici rimanendo furbescamente in bilico tra realtà e finzione, fingendo di rispettare una distanza invece sempre infranta; abusando di un dolore reale trattato senza rigore, gettato davanti all’occhio impietoso della macchina da presa che, privo di guida, lo rende sterile, quasi pornografico. In concorso c’erano poi, ovviamente, i film italiani, una prerogativa della gestione Amelio, non curante del livello della produzione nel nostro paese (l’anno scorso in concorso c’era l’imbarazzante Henry di Alessandro Piva). I più grandi di tutti di Carlo Virzì, pur nella sua superficialità, si rivela un film dignitoso, capace di strappare qualche risata e soprattutto di fermarsi, evitando di prendersi sul serio e di scendere in profondità che evidentemente non gli appartengono. Una commedia leggera, senza pretese, che racconta con un certo affetto il mondo delle band di provincia e dei sogni infranti: nulla di più, forse non abbastanza per giustificarne la presenza a un festival. Ulidi piccola mia, invece, è un film piuttosto arrogante, fastidioso e soprattutto moralmente scorretto nell’appoggiarsi soltanto alla sofferenza delle sue protagoniste. Mateo Zoni mette in scena un gruppo di ragazze con problemi familiari e psichiatrici rimanendo furbescamente in bilico tra realtà e finzione, fingendo di rispettare una distanza invece sempre infranta; abusando di un dolore reale trattato senza rigore, gettato davanti all’occhio impietoso della macchina da presa che, privo di guida, lo rende sterile, quasi pornografico.
 I tre film “britannici” (Serbuan Maut/The Raid è diretto da un gallese e prodotto in Indonesia) concludono questa veloce panoramica su Torino 29. Ghosted di Craig Viveiros è un dramma carcerario popolato da tutte le “figure” possibili sul genere: il cattivo “sodomita”, l’omicida pentito che vuole salvare qualcuno, il giovane in attesa di un educazione alla vita in prigione, l’amico saggio ecc… Niente è fuori posto, niente però colpisce, il passato dei protagonisti emerge in maniera didascalica per mezzo di dialoghi carichi e flashback di facile lettura. Così anche il doppio ribaltamento finale con il padre putativo che si trasforma nuovamente in carnefice per espiare davvero la propria colpa lascia perplessi: troppo atteso, incapace di stupire e alquanto retorico. Serbuan Maut/The Raid e Attack The Block sono entrambi sorprendenti nella misura in cui “sorprendentemente” sono stati inseriti nel sezione concorso; presentati come “aperture” verso un cinema capace anche di intrattenere, sono due action movie diversi tra loro, ma accomunanti dall’essere entrambi piuttosto inconsistenti. Il film di Gareth Huw Evans, Serbuan Maut, è un'interminabile sequenza di assedio scritta molto male, in cui tensioni e tradimenti sono tanto improvvisi quanto incomprensibili e inutili. Girato, forse bene, come un film di Hong Kong di trent'anni fa, senza però conservarne la complessità di struttura e di riflessione morale: vuoto e confuso. Attack The Block è invece la cronaca quasi “real time” di un'invasione aliena nella periferia londinese che vorrebbe avere qualche vaga pretesa sociologica ma non è altro che un prodotto mainstream a tempo di rap, serrato e scritto con una certa esperienza (Joe Cornish, il regista, è anche lo sceneggiatore di Tin Tin di Steven Spielberg). Intrattiene, ma certo non si vedono proprio i motivi per includerlo nel concorso di un festival, e nemmeno per dedicargli più di un paio di righe. I tre film “britannici” (Serbuan Maut/The Raid è diretto da un gallese e prodotto in Indonesia) concludono questa veloce panoramica su Torino 29. Ghosted di Craig Viveiros è un dramma carcerario popolato da tutte le “figure” possibili sul genere: il cattivo “sodomita”, l’omicida pentito che vuole salvare qualcuno, il giovane in attesa di un educazione alla vita in prigione, l’amico saggio ecc… Niente è fuori posto, niente però colpisce, il passato dei protagonisti emerge in maniera didascalica per mezzo di dialoghi carichi e flashback di facile lettura. Così anche il doppio ribaltamento finale con il padre putativo che si trasforma nuovamente in carnefice per espiare davvero la propria colpa lascia perplessi: troppo atteso, incapace di stupire e alquanto retorico. Serbuan Maut/The Raid e Attack The Block sono entrambi sorprendenti nella misura in cui “sorprendentemente” sono stati inseriti nel sezione concorso; presentati come “aperture” verso un cinema capace anche di intrattenere, sono due action movie diversi tra loro, ma accomunanti dall’essere entrambi piuttosto inconsistenti. Il film di Gareth Huw Evans, Serbuan Maut, è un'interminabile sequenza di assedio scritta molto male, in cui tensioni e tradimenti sono tanto improvvisi quanto incomprensibili e inutili. Girato, forse bene, come un film di Hong Kong di trent'anni fa, senza però conservarne la complessità di struttura e di riflessione morale: vuoto e confuso. Attack The Block è invece la cronaca quasi “real time” di un'invasione aliena nella periferia londinese che vorrebbe avere qualche vaga pretesa sociologica ma non è altro che un prodotto mainstream a tempo di rap, serrato e scritto con una certa esperienza (Joe Cornish, il regista, è anche lo sceneggiatore di Tin Tin di Steven Spielberg). Intrattiene, ma certo non si vedono proprio i motivi per includerlo nel concorso di un festival, e nemmeno per dedicargli più di un paio di righe.
 Le reazioni della sala a questi due ultimi film - i più applauditi (almeno alle “prime”) - e al film di Peatock, A Little Closer, accolto al contrario da un imbarazzato silenzio seguito da qualche applauso di cortesia, sono la fotografia di ciò che è diventato il TFF. Un festival dovrebbe raccogliere attorno a sé una comunità di spettatori (cinefili o meno) con gusti ovviamente diversi, ma con un senso del cinema condiviso; una “comunità” capace alla fine delle proiezioni di stringersi intorno a film che avverte istintivamente “suoi”, come avviene alla Semaine de la Critique a Cannes, a Panorama a Berlino, come avveniva al TFF qualche anno fa. La “comunità” creatasi attorno a questo Torino Film Festival - e non vuole essere un giudizio ma una semplice constatazione - sente di dover tributare un’ovazione a un poliziotto ninja e rimane invece fredda di fronte alla disperazione vitale di una madre nella depressa provincia americana. È il frutto di una scelta fatta consapevolmente quattro o cinque anni fa; così come è una scelta consapevole compiacersi di articoli sui quotidiani nazionali che parlano di Penelope Cruz in giro per la città, di tappeti rossi e di glamour. Chi scrive sta con Kaurismaki, pensa che i tappeti rossi coprano il sangue e il cinema il sangue non dovrebbe nasconderlo ma continuare a mostrarlo con ostinazione. Le reazioni della sala a questi due ultimi film - i più applauditi (almeno alle “prime”) - e al film di Peatock, A Little Closer, accolto al contrario da un imbarazzato silenzio seguito da qualche applauso di cortesia, sono la fotografia di ciò che è diventato il TFF. Un festival dovrebbe raccogliere attorno a sé una comunità di spettatori (cinefili o meno) con gusti ovviamente diversi, ma con un senso del cinema condiviso; una “comunità” capace alla fine delle proiezioni di stringersi intorno a film che avverte istintivamente “suoi”, come avviene alla Semaine de la Critique a Cannes, a Panorama a Berlino, come avveniva al TFF qualche anno fa. La “comunità” creatasi attorno a questo Torino Film Festival - e non vuole essere un giudizio ma una semplice constatazione - sente di dover tributare un’ovazione a un poliziotto ninja e rimane invece fredda di fronte alla disperazione vitale di una madre nella depressa provincia americana. È il frutto di una scelta fatta consapevolmente quattro o cinque anni fa; così come è una scelta consapevole compiacersi di articoli sui quotidiani nazionali che parlano di Penelope Cruz in giro per la città, di tappeti rossi e di glamour. Chi scrive sta con Kaurismaki, pensa che i tappeti rossi coprano il sangue e il cinema il sangue non dovrebbe nasconderlo ma continuare a mostrarlo con ostinazione.
|